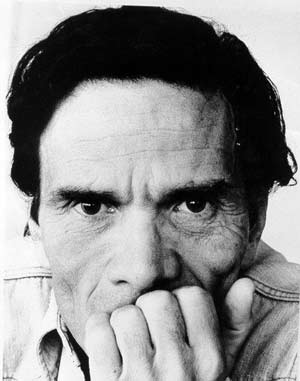Certe volte mi chiedo come mai sono così attratto dal cinema, come mai quando mi ritrovo in una sala cinematografica quasi completamente al buio - se non fosse per quel magico fascio di luce dal quale scaturiscono le storie che ci appassionano - mi sento rivivere insieme ai personaggi dei film che vedo. Me lo domando proprio ora che il (nostro) cinema italiano ha incassato due premi non da poco alla 61ma edizione del Festival di Cannes: Gran prix a Gomorra di Matteo Garrone e Premio della Giuria a Il Divo di Paolo Sorrentino. Due riconoscimenti che hanno premiato l'impegno civile di un certo tipo di cinema che, partendo dalla cruda realtà di oggi, riesce a reinventarsi ridando ancor più crudeltà agli atroci fatti di cronaca del napoletano (vedi Gomorra) e un velo grottesco - inedito e affascinante - alla figura di Giulio Andreotti (vedi Il Divo). Un'Italia come quella ben rappresentata da Garrone & Sorrentino, che sa (e vuole) riflettere attraverso la mediazione narrativa del cinema sui malanni del proprio paese, è un'Italia che ci piace. Un'Italia che, nel guardarsi allo specchio, non teme di scoprire l'indicibile realtà dei nostri giorni, è un'Italia che spera nel futuro proprio perchè ha il coraggio di combattere un presente troppo misero di speranze. E' un'Italia che ai suoi giovani può dare quell'appiglio necessario a non scoraggiarsi dinanzi a una politica che sembra occuparsi più del consenso che della reale risoluzione dei veri problemi. Più si insegue un mero consenso e più si straparla pensando solo al fascino indidioso delle parole, parole, parole... Fino ad ora i fatti li vediamo in film come Gomorra & Il Divo, e non sono poi tanto edificanti, ma almeno ci aiutano a conoscere, a non dimenticare, a crescere e a non voltare lo sguardo per non vedere il marcio che ci sta sommergendo.
Certe volte mi chiedo come mai sono così attratto dal cinema, come mai quando mi ritrovo in una sala cinematografica quasi completamente al buio - se non fosse per quel magico fascio di luce dal quale scaturiscono le storie che ci appassionano - mi sento rivivere insieme ai personaggi dei film che vedo. Me lo domando proprio ora che il (nostro) cinema italiano ha incassato due premi non da poco alla 61ma edizione del Festival di Cannes: Gran prix a Gomorra di Matteo Garrone e Premio della Giuria a Il Divo di Paolo Sorrentino. Due riconoscimenti che hanno premiato l'impegno civile di un certo tipo di cinema che, partendo dalla cruda realtà di oggi, riesce a reinventarsi ridando ancor più crudeltà agli atroci fatti di cronaca del napoletano (vedi Gomorra) e un velo grottesco - inedito e affascinante - alla figura di Giulio Andreotti (vedi Il Divo). Un'Italia come quella ben rappresentata da Garrone & Sorrentino, che sa (e vuole) riflettere attraverso la mediazione narrativa del cinema sui malanni del proprio paese, è un'Italia che ci piace. Un'Italia che, nel guardarsi allo specchio, non teme di scoprire l'indicibile realtà dei nostri giorni, è un'Italia che spera nel futuro proprio perchè ha il coraggio di combattere un presente troppo misero di speranze. E' un'Italia che ai suoi giovani può dare quell'appiglio necessario a non scoraggiarsi dinanzi a una politica che sembra occuparsi più del consenso che della reale risoluzione dei veri problemi. Più si insegue un mero consenso e più si straparla pensando solo al fascino indidioso delle parole, parole, parole... Fino ad ora i fatti li vediamo in film come Gomorra & Il Divo, e non sono poi tanto edificanti, ma almeno ci aiutano a conoscere, a non dimenticare, a crescere e a non voltare lo sguardo per non vedere il marcio che ci sta sommergendo. mercoledì 28 maggio 2008
L'Italia che ci piace
 Certe volte mi chiedo come mai sono così attratto dal cinema, come mai quando mi ritrovo in una sala cinematografica quasi completamente al buio - se non fosse per quel magico fascio di luce dal quale scaturiscono le storie che ci appassionano - mi sento rivivere insieme ai personaggi dei film che vedo. Me lo domando proprio ora che il (nostro) cinema italiano ha incassato due premi non da poco alla 61ma edizione del Festival di Cannes: Gran prix a Gomorra di Matteo Garrone e Premio della Giuria a Il Divo di Paolo Sorrentino. Due riconoscimenti che hanno premiato l'impegno civile di un certo tipo di cinema che, partendo dalla cruda realtà di oggi, riesce a reinventarsi ridando ancor più crudeltà agli atroci fatti di cronaca del napoletano (vedi Gomorra) e un velo grottesco - inedito e affascinante - alla figura di Giulio Andreotti (vedi Il Divo). Un'Italia come quella ben rappresentata da Garrone & Sorrentino, che sa (e vuole) riflettere attraverso la mediazione narrativa del cinema sui malanni del proprio paese, è un'Italia che ci piace. Un'Italia che, nel guardarsi allo specchio, non teme di scoprire l'indicibile realtà dei nostri giorni, è un'Italia che spera nel futuro proprio perchè ha il coraggio di combattere un presente troppo misero di speranze. E' un'Italia che ai suoi giovani può dare quell'appiglio necessario a non scoraggiarsi dinanzi a una politica che sembra occuparsi più del consenso che della reale risoluzione dei veri problemi. Più si insegue un mero consenso e più si straparla pensando solo al fascino indidioso delle parole, parole, parole... Fino ad ora i fatti li vediamo in film come Gomorra & Il Divo, e non sono poi tanto edificanti, ma almeno ci aiutano a conoscere, a non dimenticare, a crescere e a non voltare lo sguardo per non vedere il marcio che ci sta sommergendo.
Certe volte mi chiedo come mai sono così attratto dal cinema, come mai quando mi ritrovo in una sala cinematografica quasi completamente al buio - se non fosse per quel magico fascio di luce dal quale scaturiscono le storie che ci appassionano - mi sento rivivere insieme ai personaggi dei film che vedo. Me lo domando proprio ora che il (nostro) cinema italiano ha incassato due premi non da poco alla 61ma edizione del Festival di Cannes: Gran prix a Gomorra di Matteo Garrone e Premio della Giuria a Il Divo di Paolo Sorrentino. Due riconoscimenti che hanno premiato l'impegno civile di un certo tipo di cinema che, partendo dalla cruda realtà di oggi, riesce a reinventarsi ridando ancor più crudeltà agli atroci fatti di cronaca del napoletano (vedi Gomorra) e un velo grottesco - inedito e affascinante - alla figura di Giulio Andreotti (vedi Il Divo). Un'Italia come quella ben rappresentata da Garrone & Sorrentino, che sa (e vuole) riflettere attraverso la mediazione narrativa del cinema sui malanni del proprio paese, è un'Italia che ci piace. Un'Italia che, nel guardarsi allo specchio, non teme di scoprire l'indicibile realtà dei nostri giorni, è un'Italia che spera nel futuro proprio perchè ha il coraggio di combattere un presente troppo misero di speranze. E' un'Italia che ai suoi giovani può dare quell'appiglio necessario a non scoraggiarsi dinanzi a una politica che sembra occuparsi più del consenso che della reale risoluzione dei veri problemi. Più si insegue un mero consenso e più si straparla pensando solo al fascino indidioso delle parole, parole, parole... Fino ad ora i fatti li vediamo in film come Gomorra & Il Divo, e non sono poi tanto edificanti, ma almeno ci aiutano a conoscere, a non dimenticare, a crescere e a non voltare lo sguardo per non vedere il marcio che ci sta sommergendo.
Etichette:
hic et nunc,
in my life,
taccuino cinefilo
End of their days
 Ce l'avevo da parecchio tempo sul computer, questo film dal titolo emblematico (The Bridge), in riferimento al monumentale Golden Gate di San Francisco. Palcoscenico di numerosi suicidi di persone che, con un salto dal ponte immortalato da Hitchcock in La donna che visse due volte, hanno deciso di lasciarsi (per sempre) alle spalle tutti i problemi di una vita senza qualità. Finalmente l'ho visto, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, in particolare dalla sensibilità con la quale il regista Eric Steel ha prima filmato i jumpers suicidi, e poi ha intervistato parenti e amici alla ricerca di un qualche senso da dare al loro mortale salto nel vuoto. Ebbene sì, io ci ho trovato grande sensibilità, da parte del regista, almeno nel tentativo di ridare l'umanità perduta a quei corpi in volo verso la morte, che magari per una volta - per un'ultima, maledettissima volta - hanno voluto liberare la propria coscienza dal peso insopprimibile
Ce l'avevo da parecchio tempo sul computer, questo film dal titolo emblematico (The Bridge), in riferimento al monumentale Golden Gate di San Francisco. Palcoscenico di numerosi suicidi di persone che, con un salto dal ponte immortalato da Hitchcock in La donna che visse due volte, hanno deciso di lasciarsi (per sempre) alle spalle tutti i problemi di una vita senza qualità. Finalmente l'ho visto, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, in particolare dalla sensibilità con la quale il regista Eric Steel ha prima filmato i jumpers suicidi, e poi ha intervistato parenti e amici alla ricerca di un qualche senso da dare al loro mortale salto nel vuoto. Ebbene sì, io ci ho trovato grande sensibilità, da parte del regista, almeno nel tentativo di ridare l'umanità perduta a quei corpi in volo verso la morte, che magari per una volta - per un'ultima, maledettissima volta - hanno voluto liberare la propria coscienza dal peso insopprimibiledi dover restare con i piedi per terra.
mercoledì 21 maggio 2008
La paura del silenzio
 di Massimo Gramellini
di Massimo GramelliniDei tre minuti di silenzio osservati dai cinesi per le vittime del terremoto colpiva soprattutto una cosa: il silenzio. Nelle immagini televisive nulla sembrava poter distogliere dal loro rigore quei corpi immobili e quelle labbra serrate. Un miliardo e trecentomila persone capaci di tenere la bocca chiusa e le mani ferme per tre minuti (il totale fa 7415 anni di silenzio: praticamente un’era glaciale). Il confronto con i funerali della ragazza di Niscemi assassinata dai coetanei non avrebbe potuto essere più deprimente. Applausi scroscianti alla bara, persino durante l’esecuzione del «Silenzio» da parte di un trombettiere. L’applauso in chiesa o durante le commemorazioni negli stadi è un segnale drammatico di decadenza, tanto più perché pochi sembrano darvi peso. E’ figlio della maleducazione televisiva ed esprime l’ansia di riempire un vuoto. Nelle civiltà in declino ha perso il significato originario di approvazione ed è diventato il modo di comunicare agli altri la propria esistenza. Si applaudono i morti per sentirsi vivi, senza esserlo davvero: solo dei morti viventi, infatti, possono avere tanta paura del silenzio, che li costringe a sintonizzarsi con la parte più profonda di se stessi. Ma il ribaltamento degli impulsi naturali ha trasformato il silenzio in un segnale di freddezza e l’applauso in una forma di partecipazione. I cinesi cominceranno a perdere colpi il giorno in cui scopriranno che muovere le mani e la bocca è un ottimo sistema per mettere a tacere il cuore.
La bocca della verità?
 di Dick Morris
di Dick MorrisUn candidato che non può essere eletto sta per essere nominato da un partito che non può essere sconfitto, mentre un candidato che è altamente eleggibile è il nominato di un partito destinato alla sconfitta.
Studenti d'allevamento
Oggi, gli studenti universitari non leggono più:seguono piccoli corsi di poche settimane, che si susseguono vorticosamente; e, alla fine, dopo aver saltabeccato da un piccolo corso ad un altro piccolo corso, giacciono a terra sfiniti, senza avere appreso assolutamente nulla.
lunedì 19 maggio 2008
sabato 17 maggio 2008
Il dunque della democrazia
 di Lucia Annunziata
di Lucia Annunziata Certo, i politici, le istituzioni, tutti noi, abbiamo il diritto di non essere accusati ingiustamente, e di non essere vilipesi. Come del resto chiede appunto per sé anche Travaglio. Ma questo diritto si afferma nella spiegazione, nello scontro, nella capacità, insomma, di rispondere alla guerra; non nel dettare regole preventive, quali voler conoscere prima la sceneggiatura, o le domande di una intervista, o rivedere un articolo.
Cos'è alla fine la leadership se non saper sopravvivere alle critiche? Il dunque delle democrazie più compiute delle nostre è proprio questo: cosa ci insegnano infatti le sanguinose primarie in Usa, o la vita di leader come Blair o Thatcher?
Solo da noi la leadership pare voler essere misurata unicamente dal suono di cimbali e trombette. Solo in Italia la leadership identifica il rispetto con l’unanimità di lodi, e la forza delle istituzioni con il silenzio che le circonda.
La nostra Cecità
Perché siamo diventati ciechi?
Penso che non siamo diventati ciechi.
Penso che siamo ciechi.
Ciechi che vedono.
Ciechi che, vedendo, non vedono.
venerdì 16 maggio 2008
La nostra Gomorra
 Ricordo di aver sentito parlare per la prima volta di Gomorra, sorprendente debutto editoriale di Roberto Saviano, nella primavera del 2006, durante un incontro con lo scrittore Diego De Silva in un cinema napoletano. Qui partecipai, nell'ambito di un laboratorio di critica cinematografica, alla proiezione del bel film Certi bambini, per poi iniziare una discussione sulla camorra. Fu allora che De Silva citò il libro di Saviano, e da allora non ne dimenticai più il titolo, soprattutto dal momento in cui si cominciò a parlare delle minacce dei clan dei casalesi ai danni del giovane scrittore napoletano, e dopo che gli fu assegnata addirittura la scorta armata. Da non crederci. Decisi così di acquistare il libro, e mai acquisto si rivelò essere più azzeccato. Una volta terminata l'atroce lettura, capii di aver letto un capolavoro, o meglio il capolavoro della mia generazione. Ora che è uscito nelle sale anche il film Gomorra di Matteo Garrone, le parole di Roberto Saviano a proposito di un certo tipo di letteratura (e di cinema, aggiungerei io), pronunciate durante un incontro pubblico a Ferrara con il giornalista americano William Langewiesche, assumono un significato ancor più importante:
Ricordo di aver sentito parlare per la prima volta di Gomorra, sorprendente debutto editoriale di Roberto Saviano, nella primavera del 2006, durante un incontro con lo scrittore Diego De Silva in un cinema napoletano. Qui partecipai, nell'ambito di un laboratorio di critica cinematografica, alla proiezione del bel film Certi bambini, per poi iniziare una discussione sulla camorra. Fu allora che De Silva citò il libro di Saviano, e da allora non ne dimenticai più il titolo, soprattutto dal momento in cui si cominciò a parlare delle minacce dei clan dei casalesi ai danni del giovane scrittore napoletano, e dopo che gli fu assegnata addirittura la scorta armata. Da non crederci. Decisi così di acquistare il libro, e mai acquisto si rivelò essere più azzeccato. Una volta terminata l'atroce lettura, capii di aver letto un capolavoro, o meglio il capolavoro della mia generazione. Ora che è uscito nelle sale anche il film Gomorra di Matteo Garrone, le parole di Roberto Saviano a proposito di un certo tipo di letteratura (e di cinema, aggiungerei io), pronunciate durante un incontro pubblico a Ferrara con il giornalista americano William Langewiesche, assumono un significato ancor più importante:...questo tipo di scrittura, questo tipo di sguardo, questo dare una cittadinanza universale a problemi che non sembrano averla, è il pericolo più enorme che può generare la parola. Non per niente spesso chi arriva a fare queste cose poi non può più essere fermato se non con la morte. Perchè una parola così come la fermi? Tu puoi bloccare una notizia, ma non puoi bloccare tutti gli occhi, le labbra, le lingue che iniziano a considerare proprie quelle parole, a farle proprie... Come le fermi? E' impensabile.Roberto Saviano si riferisce qui alla scrittura, allo sguardo e alla parola della grande Anna Politkovskaja. Una donna, una giornalista, e un esempio per noi tutti.
Etichette:
hic et nunc,
il libro,
in my life,
pensieri e parole,
taccuino cinefilo
Mille pezzi di noi
 Ci sono certi libri che spalancano ai nostri occhi realtà cui non avevamo mai pensato, pur avendone avuto più volte la possibilità. Guardarsi allo specchio (almeno per me), dopo aver letto Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, non potrà avere più lo stesso significato. Dovremmo affidarci davvero alla superficie (falsamente) riflettente del nostro specchio per cercare di capire chi in superficie noi siamo? Potrà mai bastare un nome e un cognome per delinearci come essere umani hic et nunc, qui e ora, senza confusioni di sorta?
Ci sono certi libri che spalancano ai nostri occhi realtà cui non avevamo mai pensato, pur avendone avuto più volte la possibilità. Guardarsi allo specchio (almeno per me), dopo aver letto Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, non potrà avere più lo stesso significato. Dovremmo affidarci davvero alla superficie (falsamente) riflettente del nostro specchio per cercare di capire chi in superficie noi siamo? Potrà mai bastare un nome e un cognome per delinearci come essere umani hic et nunc, qui e ora, senza confusioni di sorta?Ci dice Pirandello/Vitangelo Moscarda:
Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di fusione continua, quasi fluido, malleabile; mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m'avevano data; cioè vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io, non essendo io propriamente nessuno me; tanti Moscarda quanti essi erano, e tutti più reali di me che non avevo per me stesso, ripeto, nessuna realtà.
...Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo.
...Pensare alla morte, pregare. C'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno, perchè muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.
Etichette:
il libro,
in my life,
pensieri e parole
Il cimitero del Mondo
 Vi ricordate quando da alcuni quotidiani italiani cominciarono ad uscire libri di ogni genere, narrativa, gialli e soprattutto poesia? Ebbene, all'epoca, decisi di fare la raccolta dei classici della poesia (italiana e straniera) che il Corriere della Sera pubblicava in allegato ogni settimana. Ma a dire il vero, con il passare degli anni, non ho mai cominciato a leggere (come si deve) libri di poesia (tranne l'indimenticato Giuseppe Ungaretti all'epoca della tesina per l'esame di stato). Così, qualche settimana fa, ho deciso di guardare un po' tra i libri di poesia della mia biblioteca, e ho afferrato tra le mani la magnifica Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Quando ho finito di leggerla ho pensato: ma perchè ho aspettato così tanto per godere di un po' di sana poesia? Scrisse Cesare Pavese a proposito delle epigrafi di Lee Masters:
Vi ricordate quando da alcuni quotidiani italiani cominciarono ad uscire libri di ogni genere, narrativa, gialli e soprattutto poesia? Ebbene, all'epoca, decisi di fare la raccolta dei classici della poesia (italiana e straniera) che il Corriere della Sera pubblicava in allegato ogni settimana. Ma a dire il vero, con il passare degli anni, non ho mai cominciato a leggere (come si deve) libri di poesia (tranne l'indimenticato Giuseppe Ungaretti all'epoca della tesina per l'esame di stato). Così, qualche settimana fa, ho deciso di guardare un po' tra i libri di poesia della mia biblioteca, e ho afferrato tra le mani la magnifica Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Quando ho finito di leggerla ho pensato: ma perchè ho aspettato così tanto per godere di un po' di sana poesia? Scrisse Cesare Pavese a proposito delle epigrafi di Lee Masters: ...mosso (Lee Masters) da interessi culturali e morali di ben più grave portata...accentrò le sue facoltà visionarie sulla tensione etica dei suoi personaggi, i morti di Spoon River, chiedendo loro di rivelargli il segreto, la coscienza ultima delle loro azioni, e in questa severa, dantesca ansia visse il suo travaglio fantastico.
Dei tanti segreti confessati dai morti di Spoon River, questo è quello che più mi ha fatto commuovere:
FRANCIS TURNER
Da ragazzo
non potevo correre nè giocare.
Da uomo potei solo sorseggiare dalla coppa,
non bere -
perchè dopo la scarlattina m'era rimasto il cuore malato.
Eppure riposo qui
consolato da un segreto che solo Mary conosce:
c'è un giardino di acacie,
di catalpe e di pergole dolci di viti -
là, quel pomeriggio di giugno
a fianco di Mary -
mentre la baciavo con l'anima sulle labbra
l'anima d'un tratto volò via.
Etichette:
il libro,
in my life,
pensieri e parole,
sala di ascolto
lunedì 12 maggio 2008
venerdì 2 maggio 2008
Iscriviti a:
Post (Atom)