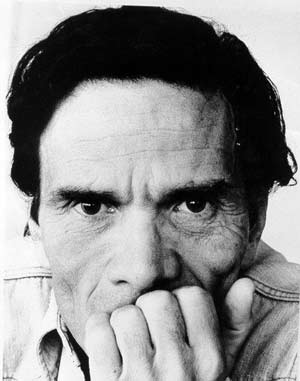La nuova Londra di Marco Niada, giornalista de Il Sole 24 Ore, è un libro (come dice il sottotitolo) sulla Capitale del XXI secolo, dove già a partire dai numeri restiamo meravigliati. Come potrebbe essere diversamente in una città con 7,6 milioni di abitanti, che entro il 2011 supererà anche gli 8 milioni? Senza contare che Londra, “dove si parlano 300 lingue e abitano persone provenienti da 90 paesi”, scrive Niada, “è sede di ben 175 ambasciate su 191 paesi membri delle Nazioni Unite”. In perfetto stile global.
D’altra parte, come ben ci spiega a suon di numeri Marco Niada, la forza di Londra è proprio questa: “facendo leva su un’apertura totale, sulla lingua inglese, ponendosi come ponte tra Oriente e Occidente, rivisitando e rafforzando i legami con le ex colonie, dagli Usa alle Indie e, soprattutto, intercettando talenti dalle classi dirigenti europea, americana e asiatica, in virtù della flessibilità del mercato del lavoro e della capacità di creare opportunità, Londra è diventata un centro globale dell’economia della conoscenza”. Una conoscenza che spazia dall’architettura alla finanza, dal giornalismo al teatro, dalla moda al cinema, fino alle prestigiose università che attirano studenti da tutto il mondo.
Una città dunque che accoglie tanti immigrati, e proprio “l’immigrazione”, sottolinea Niada, “è un termometro del successo di un paese, di una regione o di una città”, dal momento che “in un mondo sempre più globalizzato, se nessuno vuole andare a vivere in un luogo, la purezza etnica ne riflette semplicemente arretratezza economica, inacessibilità geo-politica o problemi sociali”. Ecco entrare in gioco allora il celebre teorema di Wimbledon, dal famoso torneo di tennis che, ogni anno, ospita i migliori giocatori su piazza per uno spettacolo sportivo che non manca mai di deludere gli appassionati. Come scrive Marco Niada, anche se “gli inglesi non vincono da decenni, ciò che conta è avere un buon campo, regole chiare che vengono fatte osservare, la capacità di richiamare i migliori professionisti da ogni parte del mondo e un circo mediatico-informativo in grado di proiettare l’evento ai quattro angoli del mondo”.
Volete un esempio più concreto? Pensate all’industria automobilistica britannica che, sebbene sia ora tutta in mano agli stranieri, produce la bellezza di 1,8 milioni sul proprio territorio, “quasi il doppio dell’Italia”, scrive Niada, “che ha gelosamente difeso l’industria nazionale fino a rischiare il fallimento della FIAT”. E se applicassimo il caso di Wimbledon anche al mondo universitario britannico, cosa scopriremmo? Un dato che, in quanto italiani, ci renderebbe più orgogliosi del nostro sistema accademico ma fino a un certo punto.
Secondo uno studio pubblicato nel gennaio 2007 e curato dall’addetto scientifico dell’ambasciata d’Italia a Londra, Salvator Roberto Amendolia, l’88% degli intervistati (su un campione di 150 accademici che lavorano oltre Manica) pensa “che il nostro paese dà una migliore preparazione universitaria rispetto alla Gran Bretagna”. Qual è il problema, allora? “Mettere a frutto tale educazione, insegnando e facendo ricerca”, è il vero problema made in Italy, dicono gli accademici italiani in Gran Bretagna, che al Bel Paese ci pensano spesso, ma la realtà prende poi il sopravvento e i loro sogni italiani ritornano nel cassetto. Sarà anche per questo che Londra è diventata la Capitale del XXI secolo?
 di Shashi Tharoor (The Guardian)
di Shashi Tharoor (The Guardian) from
from