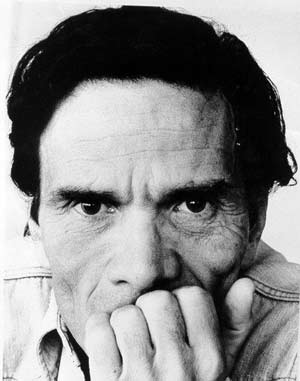lunedì 31 maggio 2010
domenica 30 maggio 2010
giovedì 27 maggio 2010
mercoledì 26 maggio 2010
Working on a dream
sto sbriciolando l’ultima immagine
e in fondo agli occhi ancora resterà
il profilo e il sogno di questa città"
giovedì 20 maggio 2010
mercoledì 19 maggio 2010
Departures, di Yojiro Takita
Daigo ha un sogno: fare carriera come violoncellista. La sua orchestra, però, non se la passa troppo bene, il pubblico pagante scarseggia ai concerti e il proprietario è costretto a scioglierla. Come potrà guadagnarsi da vivere, Daigo, senza più il suo violoncello? Difatti sarà costretto a venderlo non potendo più pagarne le rate. Con la fidanzata Mika (Ryoko Hirosue) decide di trasferirsi dalla grande e frenetica Tokyo al paesino natio (Yamagata), dove il giovane di belle speranze (ormai quasi tutte tradite) troverà un impiego a dir poco inaspettato, in qualità di ‘nokanshi’.
Tecnicamente, i ‘nokanshi’ son coloro che preparano con cura i corpi dei defunti prima di riporli nelle bare. Daigo non trova il coraggio di confessare all’amata Mika di cosa si tratti questo suo nuovo lavoro, tra l’altro pure ben retribuito. In paese non gira una bella voce su questi ‘portatori di morte’ che sembrano lucrare sulle disgrazie altrui. In realtà, e qui sta il maggior punto di forza della pellicola, il regista ci mostra la grazia con la quale Daigo comincerà a trattare quei corpi inerti ma paradossalmente ancora pieni della vita trasmessa dai parenti in lacrime.
Dinanzi a una bellissima suicida che si rivelerà poi essere un ragazzo vestito da donna, o a un’adolescente morta in un incidente stradale oppure a una nonna tanto amata dalle nipotine che si offrono di metterle per l’ultima volta i suoi calzini preferiti, il giovane ‘nokanshi’ imparerà ben presto a fare i conti con la morte. Non manca l’ironia nello sguardo del regista giapponese, capace anche di farci sorridere in situazioni cosi tragiche nel tentativo di trovare fino all’ultimo qualche sprazzo di vita inesauribile.
È possibile conservare la bellezza in eterno? Questa è la domanda che fa da sfondo alla storia di Daigo, giovane musicista che troverà dove non si sarebbe aspettato la pace dei sensi mai avuta da bambino. Alla fine – e qui il film sembra peccare un po’ di sentimentalismo – potrà anche fare i conti con il suo passato, e con un padre che solo dopo tanti anni si rivelerà per quello che davvero è stato. Sarà ormai troppo tardi per rimediare agli sbagli del tempo?
Saw VI, di Kevin Greutert
Ancora una volta ci si chiede quale senso può rivestire la violenza nel racconto cinematografico, soprattutto quando appare fine a se stessa, volta unicamente a stordire i sensi dello spettatore, costringendolo a chiudere gli occhi o a coprirseli per evitare lo spettacolo dell'orrore. Cosa è orrore e cosa non lo è? Perché mostrarlo fino in fondo? Prendendo spunto da due classiche saghe horror della storia del cinema, come Halloween e Nightmare, negli anni il fenomeno Saw ha mostrato senza remore le torbide macchinazioni dell'Enigmista, un malato terminale di cancro con un grande talento nell'ideazione di sanguinosi giochi di sopravvivenza: le vittime sono persone che hanno smesso di apprezzare il valore della vita e che meritano la morte.
La pellicola ha un gusto del macabro difficile da condividere, dal momento che la trama sembra essere solo una parentesi tra le numerose e agghiaccianti scene di violenza che a lungo andare inorridiscono e stancano. Forse sarà stato proprio questo senso dell'orrido ad averne decretato il successo fino alla sesta puntata? E pensare che per la settima si sta già pensando al 3D. Come a dire: l'orrore della violenza al cubo!
Il Work in progress tour sbarca a Milano

Lo scorso 5 maggio il duo romano-bolognese ha fatto tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove hanno deliziato il pubblico pagante - per dirla alla De Gregori - con ben tre ore di concerto. Una cavalcata musicale che è iniziata e finita con due inediti, tanto per non guardare troppo al passato remoto delle loro storiche carriere. Francesco De Gregori con cappello, occhiali scuri e armonica a bocca d'ordinanza e Lucio Dalla con il suo clarinetto hanno aperto le danze sulle note di "Over the rainbow", chiudendole dopo una ventina di canzoni con l'inedito "Non basta saper cantare" scritto a quattro mani ma con un'evidente influenza di De Gregori su testo e musica.
Un inedito capace di riassumere il senso di una serata live in bilico tra ricordi e speranze future, dove l'orecchio rivolto alle canzoni del passato (magari riarrangiate per l'occasione) è servito a non deludere una platea in cerca dei grandi successi di un tempo. Da "Anna e Marco" a "Canzone" di Lucio Dalla, da "Titanic" a "Viva l'Italia" di De Gregori (una canzone d'amore ancora sospesa tra retorica e polemica, ha detto il Principe), in un incessante palleggio tra i rispettivi repertori che, a tratti, ha rischiato di annoiare quando è mancato uno sforzo di ulteriore arrangiamento delle canzoni originali (in particolare quelle di Lucio Dalla) tipico invece dei concerti dal vivo di De Gregori, sulla scia del miglior Bob Dylan.
I momenti da incorniciare restano quelli in cui si è sentito più forte il feeling musicale tra i due, quando ogni canzone sembrava essere rinata a nuova vita come se fosse stata ricomposta per l'occasione: basti pensare a "Santa Lucia", a "La leva calcistica della classe '68", a "Due zingari" e a "La valigia dell'attore" di De Gregori, oppure a "Tutta la vita", ad "Anna e Marco", a "Come è profondo il mare" e a "Futura" di Dalla. Da brividi, invece, gli assoli di De Gregori con la sua "Donna cannone" e di Dalla con la potente "Caruso".
Non sono mancati poi alcuni simpatici siparietti tra i due vecchi compagni di banda che sul finire, fingendo di aver terminato il concerto, non si sono fatti pregare troppo per ritornare sul palco ad inanellare un'altra sessione di canzoni: da ricordare "Buonanotte fiorellino" in un'accattivante versione rock-blues e l'ultima, nuova chicca musicale a firma Dalla & De Gregori. Come a dire: senza cuore non c'è talento o voce che tenga, perché non basta saper cantare. Anche se a volte serve.
lunedì 17 maggio 2010
domenica 16 maggio 2010
venerdì 14 maggio 2010
Robin Hood, di Ridley Scott
Siamo nell’Inghilterra del XIII secolo, un paese indebolito da decenni di guerre e da un governo avido di tasse in mano a Giovanni, il fratello minore di Re Riccardo, impegnato in battaglia contro l’esercito francese. Qui ‘Cuor di Leone’, colpito da una freccia al collo, ci rimetterà le penne e la corona. Ne approfitterà proprio l’arciere Robin Longstride (Russell Crowe), che per ritornare in patria insieme alla sua banda si fingerà Sir Robert Loxley (ucciso in battaglia) con il compito di riportare a Londra la corona del defunto Re Riccardo: così nascerà Robin Loxley, meglio conosciuto come Robin Hood.
“Non so dove sono nato, ma so dove sono stato”, pensa Robin ritornando in Inghilterra, con la promessa fatta a Robert Loxley, prima che morisse, di riportare la sua spada al padre Walter (Max von Sydow) nel piccolo villaggio a Nottingham. Qui incontrerà la bella e sola Lady Marion (Cate Blanchett), con la quale nascerà a poco a poco l’amore. Sulla spada di Loxley c’è una scritta: “Rise and rise again until lambs become lions” (ribellarsi e ribellarsi ancora finché gli agnelli diverranno leoni). Robin comincerà così a pensare di essere stato prescelto dal fato per combattere, al fianco del popolo oppresso, contro la corruzione della corona del Principe Giovanni, non prima però di aver sventato la minaccia del nemico francese che sta tramando alle spalle degli inglesi ad opera di Sir Godfrey (Mark Strong).
Ridley Scott ritorna sui suoi passi, quelli de Il Gladiatore, sia per la presenza di Russell Crowe che per le violente sequenze di battaglia molto coinvolgenti. Ma il suo Robin Hood non si riduce solo a questo, bensì riesce – come ha fatto Christopher Nolan per l’uomo pipistrello in Batman Begins – a decostruire una leggenda raccontandone la storia prima del mito, con ironia e la giusta dose di sensazionalismo in salsa hollywoodiana.
Un film che diverte anche grazie ad una credibile ricostruzione visiva dello scenario storico – siamo tra il 1199 e il 1215, anno della firma della Magna Carta – e alle ottime interpretazioni degli attori, su tutti Russell Crowe, Cate Blanchett e William Hurt nei panni di Guglielmo il maresciallo. La pellicola termina nella foresta di Sherwood dove finisce la storia di un uomo e inizia la leggenda di un eroe: dobbiamo aspettarci un sequel?
giovedì 13 maggio 2010
Il ladro di parole
Quando Mark ci riprova, a fare il verso ad uno dei suoi autori preferiti, Ernest Hemingway, questa volta gli va meglio. Di stanza a Parigi riesce a spacciare casualmente - e qui l'amore ci metterà lo zampino - quel suo falso scritto di Hemingway per uno dei manoscritti che lo scrittore americano smarrì tempo indietro a causa della moglie. Ad approfittarne per farsi un po' di soldi è il padre di Helen, la ragazza alla quale Mark dà lezioni di inglese. Il giovane protagonista cerca di cavarsela come può tra l'università che non gli va proprio a genio, e la madre che di lì a poco morirà lasciandolo in una solitudine fatta di libri e speranze. Decide così di iniziare una nuova vita a Londra, dove riuscirà a strappare una collaborazione (gratuita) con la Little Review, una rivista di libri sull'orlo del fallimento.
Quale miglior occasione per risollevare le sorti in edicola della sua piccola creatura di carta, spacciando alcuni dei suoi falsi racconti per quelli inediti di grandi autori del passato? Il gioco apparentemente funziona, e il lettore segue con trepidazione l'evolversi della scommessa editoriale di Mark. «Avevo passato tutta la vita a sentirmi invisibile - pensa tra sé il giovane aspirante scrittore - Credevo che scrivere fosse un modo per realizzarmi, ma finora mi aveva solo reso ancora più invisibile».
Al di là della trama, il romanzo di David Belbin affascina soprattutto per le sottotracce di carattere letterario affrontate sullo sfondo delle vicende narrate: che vuol dire essere uno scrittore? Come fare per diventarlo? È possibile fingere, senza farsene accorgere, quando si scrive? È vero che «i cattivi scrittori copiano» mentre «i buoni scrittori rubano»? Di certo L'inedito di Hemingway non vuole dare tutte le risposte a queste domande, evidenziando però come la vita resta dopo tutto «un soggetto inesauribile» da cui attingere, e che spesso «la fortuna e il tempismo sono molto più importanti del talento». Lo sa bene Mark che ha saputo cogliere, finché ha potuto, l'occasione di una vita pur rischiando di perdere tutto in un attimo.
«La verità di un uomo è in quello che non dice», si legge in una biografia di Ernest Hemingway. Mark Trace, l'eterno simulatore protagonista di questo libro a metà tra thriller e romanzo di formazione, la sua verità ce la racconta in prima persona nella consapevolezza che «nessuno trova la sua voce e tutti rubano quella di qualcun altro e la migliorano». Talento permettendo, naturalmente.
Severgnini, intervista con pepe
«Non è vero che sono il principe degli intervistatori italiani», si è schernito Severgnini che di chiacchierate in televisione con personaggi famosi – da Bruce Springsteen a Madonna fino a Michael Moore - ne ha fatte parecchie in giro per il mondo. D’altra parte, le sue più grandi passioni sono due: i viaggi e le interviste. Con la solita arma d’ordinanza, quella dell’ironia, Severgnini ha spiegato come l’intervista (scritta o televisiva) sia «uno dei modi di fare giornalismo», e che quasi sempre avviene in presenza di due persone: l’intervistato e l’intervistatore. Non è sempre così, però, ha scherzato il giornalista ricordando l’incontro con Dolce & Gabbana che si portarono dietro anche il cane. Come a dire: quando si fa un’intervista può succedere di tutto, basta farsi trovare pronti.
Ecco perché è importante avere personalità, «non troppa ma neanche troppo poca». Per Severgnini non bisognerebbe mai essere eccessivamente aggressivi, come spesso succede nel mondo anglosassone dove è facile trovare due tipologie di giornalisti: «Gli aggressivi stupidi e gli aggressivi bravi». Altra regola imprescindibile: mai e poi mai gareggiare in egocentrismo con il proprio intervistato, senza però fargli da zerbino. Cosa buona e giusta sarebbe anche quella di studiare le varie tecniche di risposta per non farsi cogliere impreparati. Mostrando l’intervista fatta per la Rai a Bruce Springsteen, Severgnini ha evidenziato una delle migliori qualità che un intervistato possa avere: pensare in fretta.
Educazione prima di tutto: è l’ulteriore suggerimento del giornalista se si vuole evitare che «l’intervistato si chiuda in se stesso, smetta di rispondere alle domande o addirittura si alzi e vada via». Tenendo presente che «le persone preferiscono sempre e dovunque farsi intervistare da uomini di fiducia, la scortesia non fa mai buon giornalismo». Altre regole fondamentali: «Prepararsi ma non troppo» nella consapevolezza che «bisogna andare oltre Google per fare le proprie ricerche» e «non chiedere conferme su cose che chi parla ha già detto in altre interviste». D’altra parte, compito del giornalista è di «far esprimere idee nuove alla persona che intervista».
Non da meno è la creazione di un rapporto di empatia tra intervistato e intervistatore. Severgnini ha fatto l’esempio dell’intervista scritta senza registratore – quella che gli inglesi chiamano portrait – dove chi risponde alle domande è quasi ostaggio di chi le fa: viene a crearsi così «una sindrome di Stoccolma dell’intervistato di cui non bisogna mai abusare». Ma il vero segreto della buona intervista è abbandonarsi alla serendipity, l’arte di trovare quel che non si sta cercando: «Lasciate spazio alla sorpresa – ha detto Severgnini – e ascoltate le risposte dell’intervistato». Sempre.
mercoledì 12 maggio 2010
martedì 11 maggio 2010
L'uomo nell'ombra, di Roman Polanski
Misteriosamente, però, McAra viene ritrovato senza vita su una spiaggia della costa orientale degli Stati Uniti, dove l’ex premier britannico si tiene a debita distanza dagli occhi famelici della stampa internazionale. Per questo viene ingaggiato, a tempo di record, un altro ghost writer (Ewan McGregor) – di cui non si saprà mai il nome – con il compito di finire la biografia di Adam Lang nell’arco di un mese, per l’invitante cifra di 250 mila dollari. Il ghost writer dovrà però trasferirsi negli Stati Uniti per andare a intervistare il suo cliente. All’inizio è titubante, venuto a conoscenza delle grane giudiziarie piombate addosso al politico britannico, ma alla fine decide di fare le valigie e partire. Sembra quasi che il libro sulla vita di Lang sia più una bomba pronta ad esplodere che una semplice biografia, seppur pagata a peso d’oro.
Una volta giunto a destinazione, lo scrittore ombra si rende conto dell’isolamento che circonda la vita da presunto criminale di guerra dell’ex primo ministro. Qui incontrerà la moglie di Lang, Ruth (Olivia Williams), con la quale nascerà un rapporto di confidenza: entrambi sembreranno due ombre al cospetto del gigante politico incriminato dalla giustizia internazionale. Pian piano, però, saranno proprio loro a distinguersi nell’evolversi della storia, svelando segreti inconfessabili e imprevedibili.
Il regista Roman Polanski, traendo spunto dal romanzo Il ghostwriter (Mondadori) di Robert Harris, ha realizzato un thriller accattivante e coinvolgente. La scelta della location dove esiliare Adam Lang ha contribuito ad accrescere il senso di impotenza del ghost writer dinanzi ai segreti impronunciabili del potere. Fino all’ultima sequenza – perfettamente riuscita – la verità non viene svelata, lasciando allo spettatore la libertà di congetturare sui misteri della vicenda.
Qualcuno ha voluto intravedere, tra le righe della storia di Robert Harris, un non troppo velato accenno alla parabola di Tony Blair (di cui Harris è stato collaboratore). Resta comunque il senso di angoscia di un film capace di rendere su pellicola l’eterno quesito che il comune cittadino si pone ogni giorno: quale oscura verità si nasconde dietro al potere della politica?
Vendicami, di Johnny To
Questa è la domanda che ci si pone dinanzi all’ultimo film di Johnnie To, Vendicami, storia di violenza e amicizia sullo sfondo della malavita di Hong Kong. La violenza è tutto, come anche lo stile, per Johnnie To, che sin dalle prime scene non ci risparmia sequenze ad alto tasso di sangue. Non manca poi l’ironia, soprattutto nella caratterizzazione di alcuni personaggi, quasi a voler esorcizzare il senso di morte che aleggia sulla missione di Costello & Co. Peccato, però, che a lungo andare l’azione fine a se stessa prevalga sul resto, lasciando lo spettatore in balia di sparatorie tanto eccessive quanto gratuite. Ce n’era davvero bisogno? Indimenticabile, invece, l’interpretazione (nel ruolo di Costello) di Johnny Hallyday, celebre cantante e attore francese, capace anche solo con il gelo dello sguardo di trasmettere il desiderio di vendetta che gli brucia dentro.
lunedì 10 maggio 2010
domenica 9 maggio 2010
Don't stop believing...
sabato 8 maggio 2010
venerdì 7 maggio 2010
Twin Peaks vent'anni dopo
Correva la primavera del 1991 quando su Canale 5 andò in onda, per la prima volta in Italia, la puntata d’esordio della serie televisiva Twin Peaks. In occasione dell’ottava edizione del Telefilm Festival di Milano, Aldo Grasso, direttore all’Università Cattolica del Ce.R.T.A. (Centro di ricerca sulla televisione e l’audiovisivo), ha tenuto al cinema Gnomo una lezione speciale a vent'anni dall’arrivo sugli schermi italiani della celebre serie tv ideata dal regista David Lynch.
«Sin dalla prima puntata – ha evidenziato Grasso - erano due le cose a richiamare l’attenzione del pubblico. Il cartello che dava il benvenuto a Twin Peaks, una cittadina al confine con il Canada che solo apparentemente sembrava un’isola felice, e una domanda che rimbombava nelle teste degli spettatori: Chi ha ucciso Laura Palmer?». L’apparente felicità della città e l’omicidio della giovane reginetta del liceo segnano stilisticamente la serie anche grazie all’apporto di personaggi indimenticabili. Basti pensare all’agente dell’FBI Dale Cooper, ossessionato dalla ricerca dell’assassino di Laura Palmer e ghiottissimo di caffè e crostate di ciliegie.
«La cosa interessante – prosegue Aldo Grasso – è da una parte la detective story che si snoda alla ricerca dei colpevoli della morte della ragazza, e dall’altra una dimensione tra reale e soprannaturale tipica anche della celebre serie tv Ai confini della realtà». In riferimento al titolo della serie Twin Peaks, che in italiano vuol dire ‘due picchi’, qualcuno – ha sottolineato il professore – ha voluto addirittura leggervi una premonizione del crollo delle Twin Towers nel 2001.
Per la prima volta in televisione entrano argomenti mai affrontati prima, segnando così l’incontro tra serialità e autorialità. Secondo Grasso la serie di David Lynch «sancisce un nuovo modo di raccontare, quello della multitrama», nella consapevolezza che l’utente televisivo non è più uno spettatore di serie B.
«Twin Peaks rappresenta il dopo Dallas perché non cerca di spiegarci dove sta il bene e dove sta il male», riuscendo a capovolgere continuamente queste categorie: il male si tramuta in bene e viceversa, rappresentando al meglio quella complessità del reale che si ritroverà poi in molte delle serie tv americane degli anni successivi. Vi dice qualcosa Lost?
mercoledì 5 maggio 2010
L'uomo dal cuore di ferro
Iron Man 2, sequel del primo film di successo uscito nel 2008, inizia qualche mese dopo la confessione di Tony Stark circa la sua reale identità. Il protagonista ha intenzione di lanciare sul mercato, durante la roboante Fiera Mondiale Stark Expo che presenta una serie di innovazioni tecnologiche rivolte al bene dell'umanità, il suo costume rosso da guerra. Ormai Tony Stark e Iron Man sono due facce della stessa medaglia, l'uno non può esistere senza l'altro, e anche per questo il protagonista si rifiuta di condividere con il governo americano il segreto delle proprie tecnologie militari.
Ma nell'ombra, dalla lontana Russia, un nemico sconosciuto a Stark, un certo Ivan Vanko (interpretato da un Mickey Rourke che sembra fare un po' il verso al suo ruolo in The Wrestler) giura vendetta contro l'uomo di ferro. Una vendetta che sarà consumata durante il Gran Premio di Formula Uno a Monaco, dove Stark - alla guida della sua vettura - verrà speronato dal russo con un'arma altrettanto potente di quella di Iron Man. Inizia da qui la crisi del protagonista alla ricerca di un antidoto per evitare che il suo cuore artificiale lo abbandoni per sempre, e forse la risposta è celata proprio dietro al progetto sulla città del futuro che il padre, Howard Stark, stava realizzando poco prima di morire.
Il film indubbiamente diverte molto, riuscendo a mescolare sapientemente la giusta dose di spettacolo e ironia, pur rischiando di esagerare nella resa dei conti finale tra Stark/Iron Man e l'esercito di droni creato dal russo Vank. A tratti, nei combattimenti tra robot, sembra di vedere le mitiche scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill proprio per la loro prevedibilità.
Niente male il resto del cast: da una splendida Gwyneth Paltrow a Don Cheadle, da una sempre burrosa (forse troppo) Scarlett Johansson a un goliardico Sam Rockwell, fino a Samuel L. Jackson. Per non parlare del protagonista assoluto, Robert Downey Jr., ormai di nuovo sulla strada della sua alba cinematografica dopo gli ultimi successi al botteghino (vedi, ad esempio, Sherlock Holmes). L'attore riesce a catalizzare su di sé tutta l'attenzione dello spettatore, affascinato dallo sguardo sbarazzino e dalla forma fisica invidiabile di un attore (quasi) di ferro. Chapeau!
martedì 4 maggio 2010
In fuga con i Foster
Cosa fare per dare una svolta al loro rapporto? A Phil viene l'idea di appropriarsi di una prenotazione altrui, in un ristorante chic di Manhattan, per poter consumare una cena di lusso senza dover aspettare dei secoli: per qualche ora non saranno più i Foster, bensì il signore e la signora Tripplehorn.
Peccato, però, che i due sposini abbiano deciso di rimpiazzare la coppia sbagliata, visto che i Tripplehorn sono in realtà due giovani ladri braccati da alcuni poliziotti corrotti per aver rubato una pen-drive contenente qualcosa di molto scottante. Così Phil e Claire si troveranno da un momento all'altro, senza nemmeno aver potuto gustarsi la cena, inseguiti da questi due piedipiatti che cercheranno in tutti i modi di recuperare la pennetta dei misteri. Così ha inizio la Notte folle a Manhattan dei Foster, il titolo della commedia diretta da Shawn Levy a base di gag spassose e inseguimenti rocamboleschi per le strade notturne di New York.
Il film cerca disperatamente di divertire lo spettatore, ma a parte alcune scene il resto scivola inesorabilmente via come l'olio, lasciando l'amaro in bocca per le potenzialità che una coppia esplosiva, come quella formata da Steve Carrell e Tina Fey, avrebbe potuto aggiungere a una storia non particolarmente originale. A "impreziosire" il cast ci sono anche Mark Wahlberg nel ruolo di un palestrato con il vizio delle donne e Ray Liotta nei panni del gangster Joy Miletto: due presenze di contorno che ci fanno rimpiangere altre loro interpretazioni (vedi Liotta in Quei bravi ragazzi). E sullo sfondo della storia c'è una New York quasi evanescente, eccessivamente da cartolina, che avremmo voluto venisse valorizzata meglio.
Il giovane Salinger
A 91 anni ci ha lasciato con un dubbio: in tutti questi anni di isolamento avrà scritto qualche altro romanzo? Molti se lo stanno chiedendo, e le ipotesi sono le più varie. C'è chi pensa che Salinger non abbia scritto nemmeno una riga, chi invece teme che lo scrittore abbia deciso di bruciare tutto prima di morire, e chi addirittura ipotizza uno scenario alla Shining. Vi ricordate cosa faceva Jack Nicholson/Jack Torrance nel film diretto da Stanley Kubrick? Scriveva sempre la stessa frase su quel suo foglio bianco. Ipotesi forse troppo fantasiosa, magari utile ad alleviare la voglia irrefrenabile di stringere tra le mani una nuova opera di Salinger nella speranza, prima o poi, che da qualche cassetto impolverato esca fuori.
Per consolarci basterebbe anche solo riaprire le pagine di quel The Catcher in the Rye pubblicato nel 1951, con un giovane Holden Caulfield a narrare in prima persona le sue disavventure scolastiche e non, alla ricerca di un proprio spazio nel mondo. E fu subito bestseller, grazie ad una comprensione dell'universo adolescenziale che ne rese la lettura quasi un immancabile rito di passaggio.
I critici elogiarono ancor di più i Nove racconti, pubblicati nel 1953, perfetti nel catturare i dialoghi della gente comune. Lo scrittore, infatti, sapeva far parlare i suoi protagonisti così come avrebbero parlato nella realtà di tutti i giorni. Forse per questo Dave Eggers ha ammesso di servirsi degli scritti di Salinger per mostrare ai propri studenti quanto sia importante cosa dicono i personaggi, e ancor di più come lo dicono.
«C'è una meravigliosa pace nel non pubblicare, pubblicare è una fastidiosa invasione della mia privacy - disse Salinger a un reporter - Mi piace scrivere, adoro scrivere. Ma scrivo solo per me stesso». Visse così per oltre cinquant'anni nel suo rifugio all'ombra del mondo, tra le campagne di Cornish nel New Hampshire. Nell'autunno del 1953 fece amicizia con alcuni ragazzi e permise loro di intervistarlo per un articolo che lui pensava sarebbe stato relegato nelle pagine interne del giornale locale The Claremont Daily Eagle: l'articolo apparve però nella pagina degli editoriali e, sentendosi imbrogliato, tagliò i contatti con quei ragazzi.
Un po' come fece con i suoi lettori, orfani per mezzo secolo del loro migliore amico e scrittore, di quella razza che vorresti poter «chiamare al telefono tutte le volte che ti gira». «Grazie a Dio è finalmente morto. Stavo aspettando questo giorno da sempre. Stasera si festeggia», ha scritto invece lo scrittore Bret Easton Ellis su Twitter, volendo a modo suo rendere omaggio ad un autore tanto amato quanto odiato, e mai ignorato. A maggior ragione dopo la morte. Riposa in pace giovane Salinger.
Il profeta, di Jacques Audiard
Dietro le sbarre la disperazione cresce, soprattutto quando verrà costretto da un boss ad uccidere senza pietà un altro detenuto. Come dire: ‘mors tua vita mea’. E Malik, dopo tante perplessità, riuscirà non senza difficoltà ad uccidere a sangue freddo il suo agnello sacrificale, guadagnandosi così la protezione all’interno del carcere. Ma il senso di colpa per aver ucciso Reyeb – questo il nome della prima vittima – lo tormenterà per il resto dei suoi giorni in prigione. Lo spettatore vedrà così il protagonista chiacchierare spesso in cella con la visione immaginaria di Reyeb, che prima di morire gli aveva dato il miglior consiglio mai ricevuto: “L’obiettivo è uscire di prigione meno coglione di quanto sei entrato”.
Malik, infatti, non sa né leggere né scrivere, e per questo deciderà di iniziare a studiare parallelamente al suo apprendistato da piccolo boss alle dipendenze di Cesar Luciani, il padrino indiscusso del carcere. Nelle dinamiche dietro le sbarre ci si mettono anche le differenze etniche, con gli arabi sempre più isolati dal resto dei detenuti. Anche Malik ha origini arabe, sebbene sin da bambino parli correntemente il francese, a rappresentare bene le nuove generazioni nate e cresciute in Francia. Ma il mondo di Malik è un mondo a parte, dove violenza e paura sono facce della stessa medaglia, dove il rispetto per l’altro va a braccetto con il timore di pestare i piedi alla persona sbagliata.
Il film di Audiard sorprende positivamente per la capacità di caratterizzare realisticamente la violenta vita quotidiana in un carcere multietnico, dove perisce chi non ha la forza di difendere, anche a costo di uccidere, il proprio spazio vitale. Grande interpretazione del giovane attore Tahar Rahim, nei panni dell’indimenticabile protagonista del film. Ottima prova anche di Niels Arestrup, nel ruolo dello spietato e senza scrupoli Cesar Luciani. Soltanto l’eccessiva lunghezza del film rischia a tratti di spezzare la tensione accumulatisi nel corso della narrazione. Una pellicola che comunque arriva dritto allo stomaco senza mediazioni di sorta, riuscendo a lasciare un segno indelebile nello sguardo dello spettatore.
L'inferno di Precious
Precious è una ragazza nera di Harlem - protagonista del film diretto da Lee Daniels (Precious, appunto) - alle prese con seri problemi di obesità e con un sogno nel cassetto: cantare. Per ora il suo sogno è solo un miraggio, dovendo giorno dopo giorno tirare a campare per comprarsi da mangiare, andare a scuola e sopportare gli incubi di un passato che ritorna spesso a galla: le violenze di un padre che l'hanno fatta diventare troppo presto una madre ancora giovane e immatura.
Quella maturità Precious la conquisterà a suon di umiliazioni sulla propria pelle, decidendo da sola, e contro il parere della madre, di iscriversi a una scuola per ragazze disagiate al fine di imparare tutte quelle cose che gli erano state impedite di apprendere prima. Ma soprattutto per condividere un percorso in comune con altre persone, per sentirsi meno sola ora che si sta preparando a partorire il secondo figlio. Qui incontrerà una maestra che la spingerà, sin dal primo giorno, a scrivere i suoi pensieri su un diario, che diventerà lo sfogo su carta di una ragazza con un peso sulle spalle e nel cuore pari almeno al peso del suo grande corpo.
Anche il viaggio più lungo inizia con un passo, è la morale sottesa alla storia narrata da Lee Daniels, che alla 62esima cerimonia degli Oscar ha visto trionfare - come miglior attrice non protagonista - proprio la madre padrona di Precious, interpretata da una brava Mo'Nique. Encomiabile anche la performance della debuttante, ma davvero sicura e incisiva come una vera star, Gabourney 'Gabby' Sidibe nei panni della protagonista del film.
La pellicola, a tratti un po' mielosa nel rappresentare i moti dell'animo della ragazza, riesce altresì a descriverne la crescita morale con piglio sincero e per certi versi fantastico, servendosi spesso delle visioni di Precious per mostrarne con ironia la voglia irrefrenabile di fuggire dal proprio inferno personale e imboccare finalmente la strada agognata della felicità. Un film che colpisce al cuore, forse anche troppo.
La vendetta di Gibson
La pellicola - basata sull'omonima serie televisiva andata in onda sulla BBC venti anni fa - sembrerebbe rientrare a pieno nel genere thriller, ma da subito si comprende che il passo lento dell'elaborazione del lutto paterno riveste un'importanza maggiore agli occhi del regista. Non a caso Fuori controllo inizia con alcuni filmini amatoriali in cui Emma è protagonista sulla spiaggia e al mare dei ricordi di un padre legato ad un passato felice e ad un presente spento e solitario.
Durante il film, diverse volte Thomas Craven sentirà e vedrà la voce e l'immagine di Emma, quasi a cercarne conforto e aiuto nel prosieguo delle indagini. La figlia lavorava come stagista alla Northmoor, azienda specializzata in ricerca privata, top secret per i suoi contratti con il governo americano. Il detective si troverà così invischiato in un mondo fatto di spionaggio industriale, collusioni governative e omicidi. Non sarà solo Emma a morire, ma anche altri personaggi - colpevoli di aver spifferato all'esterno le attività illecite della Northmoor - perderanno la vita in situazioni rocambolesche e prevedibili da lasciare (spiacevolmente) sorpresi.
Nelle sue sequenze più smaccatamente di azione, infatti, il film di Campbell risulta telefonato e ripetitivo senza scatti di originalità capaci di catturare l'attenzione dello spettatore. Tutto sembra rimanere in superficie, privo di un adeguato scavo psicologico dei personaggi, spesso costretti dalla sceneggiatura a recitare le solite frasi ad effetto. Insomma, un film senza pretese, con scatti di rabbia e qualche colpo di sonno.
L'amore oltre le sbarre
Enzo ha finito di scontare la sua pena dietro le sbarre e fa ritorno nella sua città d'adozione, Genova, dove l'aspetta Mary e un piccolo grande sogno in comune: andare a vivere in una casetta in campagna, sopra la città e il mare, quasi a voler contemplare un paesaggio in continua mutazione come la loro vita insieme. Enzo e Mary, infatti, non hanno sempre vissuto vicini; conosciutisi in carcere, per anni si sono sentiti dentro e fuori le sbarre attraverso delle registrazioni su cassetta (che Pietro Marcello ci fa sentire durante il film). Quegli pseudo messaggi in bottiglia hanno permesso alla coppia di restare fedele a se stessa nonostante la lontananza.
Sullo sfondo assistiamo alle immagini di repertorio di una Genova ormai scomparsa, ripresa da cineoperatori amatoriali che sono riusciti a catturare l'anima di una città sospesa tra terra e mare. Il merito del regista è di aver fatto un po' di archeologia della memoria attraverso il mezzo cinematografico, per riscoprire lo stato attuale di un luogo tramite il racconto di una storia (in questo caso d'amore) esemplare. Perché una città è la summa di piccole e grandi storie quasi tutte consumatesi all'ombra della Storia, che una volta rivelate - come quella di Enzo e Mary - ci aprono squarci di realtà altrimenti invisibili.
«Il mio sguardo sul presente - dice Pietro Marcello - è quello di un forestiero che racconta ciò che vede dalla finestra, lo sguardo sul passato e sulla grande Storia è rappresentato dai genovesi che silenziosamente sono riusciti a raccontarla attraverso l'oculare di una cinepresa». Un capolavoro italiano da non perdere, sulle orme del miglior Pasolini.

 The New Yorker
The New Yorker





 The New Yorker
The New Yorker