 “Se si prende come riferimento la storia degli Stati Uniti”, ha scritto l’imprenditore americano James Mc Gregor nel libro “One Billion of Customers”, “è come se la Cina avesse vissuto nell’arco di soli quindici anni il capitalismo selvaggio dei grandi magnati della fine dell’Ottocento, la follia speculativa degli anni Venti, l’esodo rurale degli anni Trenta, l’emergere del ceto medio consumista degli anni Cinquanta e gli sconvolgimenti sociali e di costume dei nostri anni Sessanta”.
“Se si prende come riferimento la storia degli Stati Uniti”, ha scritto l’imprenditore americano James Mc Gregor nel libro “One Billion of Customers”, “è come se la Cina avesse vissuto nell’arco di soli quindici anni il capitalismo selvaggio dei grandi magnati della fine dell’Ottocento, la follia speculativa degli anni Venti, l’esodo rurale degli anni Trenta, l’emergere del ceto medio consumista degli anni Cinquanta e gli sconvolgimenti sociali e di costume dei nostri anni Sessanta”.In soli quindici anni, dopo che Deng Xiaoping ha spianato la strada cinese all’economia di mercato. Una scelta che, ancora oggi, non smette di ripercuotersi sui ruggenti tassi di crescita della Cina. Basti pensare che nella classifica di “Business Week” delle 500 multinazionali più grandi del mondo, sono entrate 18 nuove imprese cinesi.
E proprio qui sta la sfida che l’Impero Cinese sta vincendo, malgrado i deboli richiami alla democrazia dei paesi occidentali. Una sfida volta ad equilibrare, ad uso e consumo del Partito comunista cinese, dirigismo in politica e liberismo in economia.
Ma per quanto ancora potrà durare questo paradosso made in China? Almeno fino a quando soprattutto i paesi più ricchi troveranno vantaggioso approfittare della manodopera cinese a basso costo.
Altrimenti perché il 60% delle esportazioni dalla Cina verrebbe fabbricato a nome di multinazionali statunitensi, giapponesi, tedesche, francesi, inglesi e italiane? “Una vera guerra mercantile contro la Cina” sottolinea Rampini “finirebbe per colpire anche loro”, ovvero le nostre multinazionali.



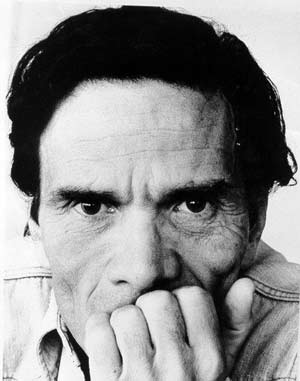




Nessun commento:
Posta un commento